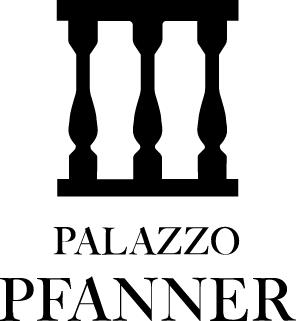AUDIO
Con il suo scenografico zampillo centrale la fontana ottagonale si trova all’intersezione dei due assi perpendicolari del giardino, a metà percorso tra la limonaia e la facciata del Palazzo. Posta nel cuore del giardino formale ed inserita lungo la direttrice di statue e conche di limoni che dal Palazzo conduce all’ingresso della limonaia, la fontana crea un’oasi di pace e freschezza in mezzo ai fiori che crescono sui suoi bordi e alle quattro statue d’ispirazione mitologica, e «di non volgare scarpello», che si rispecchiano nelle sue acque. Con lo sguardo rivolto al corpo centrale del Palazzo, emerge da uno dei suoi lati, sopra una scogliera, un puttino marmoreo da cui zampillano quattro getti d’acqua e le cui mani sostenevano un tempo un cartiglio con incisa la seguente frase: «Irae vi non gignit neque gignit vae vivum».
Stando alle testimonianze scritte e alle planimetrie dell’epoca, la fontana fu inserita ai primi dell’Ottocento al posto di un edificio a due piani, «squisito di architettura e adorno di sculti marmi», in cui risiedeva un ramo collaterale della famiglia Controni.
Felix Pfanner, in ricordo dei suoi anni giovanili trascorsi sulle sponde del lago di Costanza, era solito, durante l’estate, remare su una barchetta all’interno della fontana e, durante il rigido inverno, pattinare sulla sua superficie ghiacciata.